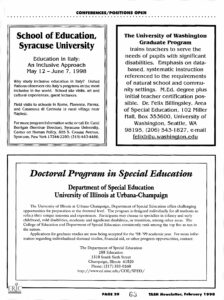[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”-64px|||||” custom_padding=”0px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” min_height=”2359px” custom_margin=”26px|auto||auto||” custom_padding=”32px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”]
 Conobbi Giancarlo Cottoni nei primi anni Ottanta, probabilmente in occasione di uno dei vari Corsi di aggiornamento che egli, periodicamente, conduceva per sensibilizzare − ed “attrezzare” − il personale della scuola alla sfida sempre crescente posta dalla integrazione degli alunni con disabilità. Difatti, quale coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione scolastica costituito in seno all’Ufficio Scolastico Provinciale, egli era il motore delle iniziative che da lì traevano origine, che miravano a fornire al personale – specialmente ai docenti, ma non solo – orientamenti nell’ambito pedagogico e didattico. Va ricordato che legge n. 118/1971, la prima a sancire che «l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica» e soprattutto la Legge 104/1992, avanzatissima al momento della sua apparizione, avevano “sparigliato le carte” nella cartella degli insegnanti, dato che da quel momento diventava necessario realizzare una medesima scuola per tutti, ma in modo tale da non proporre a tutti né gli stessi percorsi, né gli stessi strumenti, né le medesime mete. Un “terremoto culturale” non da poco…
Conobbi Giancarlo Cottoni nei primi anni Ottanta, probabilmente in occasione di uno dei vari Corsi di aggiornamento che egli, periodicamente, conduceva per sensibilizzare − ed “attrezzare” − il personale della scuola alla sfida sempre crescente posta dalla integrazione degli alunni con disabilità. Difatti, quale coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione scolastica costituito in seno all’Ufficio Scolastico Provinciale, egli era il motore delle iniziative che da lì traevano origine, che miravano a fornire al personale – specialmente ai docenti, ma non solo – orientamenti nell’ambito pedagogico e didattico. Va ricordato che legge n. 118/1971, la prima a sancire che «l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica» e soprattutto la Legge 104/1992, avanzatissima al momento della sua apparizione, avevano “sparigliato le carte” nella cartella degli insegnanti, dato che da quel momento diventava necessario realizzare una medesima scuola per tutti, ma in modo tale da non proporre a tutti né gli stessi percorsi, né gli stessi strumenti, né le medesime mete. Un “terremoto culturale” non da poco…
Approssimandosi il momento in cui avrebbe dovuto lasciare il servizio attivo per raggiunti limiti di età, Giancarlo Cottoni pensò di non disperdere l’enorme esperienza accumulata, ma anzi di porla al servizio della collettività, creando fuori dal perimetro “pubblico” una struttura espressamente disegnata per affiancare quanti – nelle scuole, nelle famiglie, nel sociale, nelle istituzioni – si trovavano a gestire rapporti umani di particolare complessità. Quella struttura, ideale continuazione e sviluppo del CEPIS deputato solo alla integrazione nella scuola, avrebbe dovuto ampliare il proprio raggio d’azione anche all’integrazione lavorativa e sociale, con il sostegno lungimirante e convinto dell’ANMIC di Parma e del Comune di Parma. Fu così che in Via Stirone iniziò a prendere forma e consistenza ciò che, più tardi, avrebbe assunto il nome di CePDI: Centro Provinciale per la Documentazione sull’Integrazione. In quel momento germinale Giancarlo Cottoni mi chiese di collaborare all’impresa, della quale solo lui possedeva in modo chiaro le coordinate. Seppure con qualche iniziale riluttanza, accettai, consapevole della sua indiscutibile professionalità. Da parte mia, potevo portare “in dote” solo un ampio orizzonte culturale e un buon grado di flessibilità operativa.
Ascoltatore e valorizzatore dei collaboratori
Cominciarono così ad affluire negli armadi del CePDI i primi “lotti” di testi, consultabili da quanti avevano bisogno di approfondire la problematica dal punto di vista didattico, pedagogico, psicologico, medico, sociale e normativo. Una biblioteca assolutamente specializzata, una “mosca bianca” si potrebbe dire. In quel primo periodo mi venne affidato il compito di selezionare i titoli da acquistare, che poi sottoponevo all’attenzione di Giancarlo. Egli esaminava accuratamente l’elenco: talvolta c’era uno scambio di pareri su questo o quell’Autore, poi dava il via libera all’acquisto. Raggiunto il numero di diverse centinaia di volumi, la gestione della biblioteca (inventario, catalogazione, servizio prestiti) già iniziava a farsi difficile. Proposi perciò a Giancarlo di dotarci di un elaboratore elettronico. Eravamo solo all’alba dell’era digitale: il sistema operativo standard era il DOS 3.x, i dati venivano salvati/caricati tramite floppy disc, le competenze informatiche erano tutt’altro che diffuse. Pronto ad accogliere ogni utile suggerimento, Cottoni provvide all’acquisto presso il concessionario locale di un noto marchio italiano. Nell’uso pratico la macchina rivelò presto i propri limiti: all’epoca i produttori, infatti, creavano soprattutto attrezzature destinate alla grande industria o ai grandi Enti erogatori di servizi, in cui occorreva un poderoso “server” centrale, cui affluivano i dati inviati da postazioni periferiche, deputate essenzialmente all’input di dati. Periferiche “povere” perciò di RAM e di storage, proprio come il nostro recente acquisto. Segnalai la difficoltà a Giancarlo: subito mi chiese di approfondire il problema, e di trovare possibilmente una soluzione. Appurai così che stavano affacciandosi sul mercato quelli che oggi chiamiamo “personal computer”, frutto di una architettura micro-computerizzata, che permetteva di progettare e realizzare dispositivi più economici, meno ingombranti e dalle prestazioni superiori. Riferii tutto ciò a Cottoni, il quale senza esitazione, ottenuta l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione, mi incaricò di identificare ed ordinare un PC con quelle caratteristiche. Fu così che – quale frutto di una collaborazione “alla pari”, pur nella indiscussa distinzione dei ruoli − compimmo i primi passi per l’efficace gestione della Biblioteca del CePDI, che di lì a pochi anni avrebbe raccolto diverse migliaia di volumi, attivando altresì una convenzione con l’Università di Parma.
In un momento successivo Giancarlo ritenne fosse giunto il momento, per il CePDI, di realizzare dei Corsi di Aggiornamento rivolti al personale della scuola, e mi chiese di farmi carico della loro organizzazione. Nonostante fossi sprovvisto di esperienza “attiva” in quel settore, con il suo incoraggiamento cominciai a delineare dei progetti. Evidentemente Cottoni riponeva fiducia in me, poiché − anno dopo anno − mi lasciò carta bianca nella individuazione delle tematiche e dei Relatori. Naturalmente mi confrontavo con lui, man mano che le “caselle del quadro” si andavano riempiendo, potendo sempre contare su qualche suo utile suggerimento. I Corsi ebbero un buon successo, tanto che il CePDI poté chiedere ed ottenere nel 2004 l’accreditamento del MIUR, pervenuto dopo la doverosa e rigorosa ispezione di funzionari del Ministero dell’Istruzione.
In questa, come in tante altre occasioni, si manifestarono in Giancarlo le caratteristiche del vero dirigente: capacità di ascolto e di valorizzazione dei collaboratori, conduzione dell’ufficio quale primus inter pares, scevro da deleteri atteggiamenti autoreferenziali spesso presenti in molti “capi”. Ciò non vuol dire che Cottoni avesse uno stile di direzione “rilassato”: come era esigente con se stesso, altrettanto lo era con i collaboratori. E laddove si rendeva necessario, arrivava pronto e chiaro il suo invito a una correzione di rotta.
Fine tessitore “politico”
Un aspetto di Giancarlo Cottoni che mi era inizialmente ignoto, e che scoprii in quegli anni, fu la sua straordinaria capacità di tessere rapporti non solo con le persone, ma anche con Enti e Istituzioni. Quella incredibile architettura istituzionale che sostiene il CePDI è infatti il frutto di una sua utopia fattasi concreta. Il coinvolgimento della Amministrazione Provinciale di Parma, della Azienda USL di Parma, dell’Università, le Comunità Montane, la Diocesi di Parma, la Fondazione Cariparma, la Fondazione Banca Monte Parma e molti Comuni di Parma e provincia (e tanti altri soggetti che ora mi sfuggono, con i quali mi scuso) fu un’opera titanica, da accreditare in larga misura a Giancarlo Cottoni e Alberto Mutti, Presidente dell’ANMIC parmense. Dietro richiesta di Giancarlo lo accompagnai, alcune volte, ai colloqui calendarizzati con un Assessore o un Sindaco. Non che io avessi un qualche ruolo in tali incontri: bastava – eccome! – la sua capacità di argomentare, di esporre le necessità della parte più fragile della popolazione e di proporre soluzioni operative. Pressoché regolarmente, Cottoni usciva dall’incontro con l’assicurazione che il rappresentante dell’Ente interpellato avrebbe supportato – prima in Giunta, poi in Consiglio − la proposta di aderire alla costituenda Associazione. Fu ugualmente decisiva la sua capacità di fare dialogare Giunta e uffici del Comune di Parma per l’ottenimento della sede di Via Stirone e per la formulazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; e l’indicazione dell’Assessore Danilo Amadei come Presidente del CePDI, col quale aveva collaborato in tutta la fase di promozione dell’Associazione. Per questo mi pare corretto affermare che egli aveva una indiscutibile capacità “politica”, nel senso migliore e più ampio del termine.
La dimensione internazionale
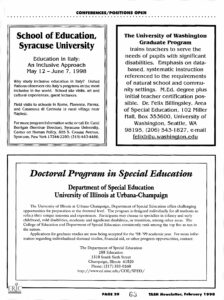
Un episodio che vale la pena di raccontare, e che forse non è adeguatamente noto, verte sulla capacità di Giancarlo di “attirare l’attenzione” come soggetto formatore nel campo della pedagogia speciale anche fuori dai confini nazionali. Nella sede del CePDI giunse, nel 1997, una studentessa statunitense. Già laureata, stava svolgendo in Italia le sue ricerche per conseguire il dottorato (il famoso Ph.D.). Era stata indirizzata proprio a Parma dalla sua Tutor negli USA, per approfondire l’evoluzione della normativa italiana in tema di handicap, e prendere conoscenza diretta delle cosiddette “buone prassi”. Conoscendo a sufficienza l’inglese, potei scambiare qualche discorso con lei. Ebbi anche modo di consultare la bozza della sua dissertazione, di ottima fattura; nella pagina iniziale era riportato il nome del co-Tutor italiano. Era, naturalmente, Giancarlo Cottoni. Il contributo di Giancarlo alla tesi statunitense fu certamente apprezzato, perché circa un anno dopo, da quello stesso Ateneo – la Syracuse University di New York – giunse a Parma la docente, la Dr. Carol Berrigan, che accompagnava un gruppo di dottorandi. Giancarlo tenne per loro una lectio magistralis sullo stato dell’arte della pedagogia speciale in Italia, rispondendo poi alle loro numerose ed “affilate” domande. Dal fitto interloquire tra gli studenti USA, al termine del contributo di Cottoni, si poteva facilmente dedurre quanto la sua esposizione fosse stata per loro profittevole, poiché ricca di indicazioni e di stimoli per ulteriori approfondimenti.
Pierluigi Arduini
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

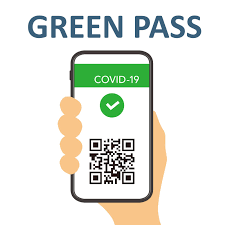 Sono cambiate le
Sono cambiate le